Il sangue È acqua.
È paradossale che una moderna scoperta come quella del DNA abbia dato nuovo vigore a un concetto arcaico come quello del ‘legame di sangue’. Attraverso l’analisi del sangue oggi si può ricostruire la paternità genetica, ma anche la discendenza di interi popoli, quindi determinare quanto di etrusco c’è nei toscani, quanto di celtico nei lombardi, e così via. Innocenti curiosità, nelle mani degli etnografi, ma cosa sarebbe successo se un simile strumento fosse stato a disposizione dei nazisti?
Il sangue, dunque, sostanza tra il biologico e lo spirituale, che dovrebbe portare con sé chissà quali richiami ancestrali, definire rapporti indissolubili e permanenti. Ha ancora un senso parlare di legami di sangue, nel nostro tempo? Il trionfo di Barack Obama infrange l’ultima barriera razziale all’interno di quello che pure è il paese più multietnico del pianeta. L’evidenza ci dimostra che i popoli più dinamici sono proprio quelli che si sono liberati di ogni criterio etnico – tribale, e che hanno acquisito la capacità di richiamare le persone più brillanti, a prescindere dalla loro nascita.
Non è un caso che la leggenda della fondazione di Roma racconti che Romolo popolò la sua città raccogliendo sbandati di ogni genere, accogliendoli sulla spianata dedicata al dio Asilo (Asylum), quella che oggi è la Piazza del Campidoglio. La città che nasce in questo modo “americano” rinnega i suoi legami tribali con Albalonga dichiarandole guerra, e sarà capitale di un impero che - come ci racconta Andrea Giardina in "L'Italia romana. Storie di un'identità incompiuta" (Laterza) - era singolarmente immune dal razzismo.
I romani, inoltre, agitati da una profonda diffidenza verso la filiazione naturale (un po' perché ‘pater semper incertus’, un po' perché genitori anaffettivi com'erano, i loro figli potevano apparire loro degli estranei) inventarono l’adozione, un rapporto di filiazione giuridica. Con l’adozione una persona adulta riconosceva in un altro adulto le sue qualità e lo chiamava figlio. La familia romana non si identificava per la continuità della linea di sangue, ma attraverso il patrimonio, finanziario ed ideale, che si tramandava tra i discendenti, naturali o adottati.
Insomma, la romanità costituisce per la prima volta un sistema di fedeltà e di legami che prescinde dal sangue.
La rivoluzione francese continuerà l’opera. La “Nazione” sostituisce il Re nella fedeltà dei cittadini, afferma i suoi diritti in antitesi al diritto dinastico del sangue, in base al quale i re avevano potuto smembrare e scambiarsi territori, e, come la familia romana, diventa un patrimonio di idee e di valori nel quale ci si può identificare a prescindere dalla nascita. La Francia, dal primo Ottocento a metà Novecento, riesce così ad attrarre ed integrare forze vive dall'estero nel suo tessuto sociale.
La storia insegna che la grandezza di un paese è data dalla sua capacità di accoglienza. Gli ebrei, cacciati dalla Spagna, furono accolti in Olanda. Lo stesso evento segnò l’inizio della decadenza della Spagna, e del Secolo d’Oro olandese.
Anche in Italia, allora, paese che è diventato di immigrazione senza mai aver veramente cessato di essere tributario dell’emigrazione, sarebbe il caso di porsi una domanda: chi è un Italiano, e chi non lo è?
 Nell'esaminare la questione debbo prima onestamente confessare la mia parzialità. Sono fiero di essere italiano, ma molto meno fiero di avere certi compatrioti. Quando il treno che mi porta al lavoro recita quella litania di borgate romane dai nomi improbabili (Ostia Antica - Acilia - Dragona - Vitinia - CasalBernocchi) non riesco a sentire alcuna affinità spirituale od etnica con certi truci soggetti che colà vivono. Mi fanno paura, e basta. Mentre invece provo viva simpatia per quei giovani sani e forti che hanno attraversato il mare e i deserti pur di venire qui a lavorare, e che sono d'esempio a una società troppo pigra e soddisfatta di sé.
Nell'esaminare la questione debbo prima onestamente confessare la mia parzialità. Sono fiero di essere italiano, ma molto meno fiero di avere certi compatrioti. Quando il treno che mi porta al lavoro recita quella litania di borgate romane dai nomi improbabili (Ostia Antica - Acilia - Dragona - Vitinia - CasalBernocchi) non riesco a sentire alcuna affinità spirituale od etnica con certi truci soggetti che colà vivono. Mi fanno paura, e basta. Mentre invece provo viva simpatia per quei giovani sani e forti che hanno attraversato il mare e i deserti pur di venire qui a lavorare, e che sono d'esempio a una società troppo pigra e soddisfatta di sé.
Sul tema dei diritti di cittadinanza, sono in libreria, per i tipi di Laterza, due interessanti studi: “Cittadinanze. Appartenenza e diritti nella società dell'immigrazione” di Laura Zanfrini, e “Familismo Legale. Come (non) diventare italiani” di Giovanna Zincone.
La più recente legge italiana sulla cittadinanza, L. n° 91 del 1992, rafforza il criterio dello ius sanguinis, rende più facile acquisire la cittadinanza ai discendenti di emigrati italiani (dai 30 ai 60 milioni), e ben più difficile agli stranieri. È una legge etnica. Dunque razzista.
È ovviamente impossibile che la comunità dei residenti e la comunità dei nazionali coincidano perfettamente. Ma la legge del 1992 anziché tendere a collimare le due cose, ha introdotto un fortissimo scollamento tra chi è ‘in Italia’ e chi è ‘Italiano’. Una legge di retroguardia, mirata a rincorrere l’emigrazione italiana, piuttosto che ad integrare i nuovi arrivati. Il risultato è stato, come ho già scritto, di creare all’interno del paese una comunità di meteci, persone di serie B, discriminate non solo rispetto ai cittadini residenti, ma pure rispetto agli extracomunitari di lontane origini italiane che vivono tuttora all’estero.
Inoltre, la nuova legge elettorale (con le modifiche costituzionali che, caso unico al mondo, hanno suddiviso l’intero pianeta in circoscrizioni elettorali nazionali) ha attribuito un peso talvolta determinante al voto degli italiani all’estero. Insomma, degli affari italiani, delle scelte politiche, economiche, dall’allocazione della spesa pubblica, possono essere arbitre persone che hanno lasciato l’Italia, ovvero non vi hanno mai messo piede, e che comunque non vi lavorano, non vi producono e non vi pagano le tasse. Risultato paradossale di politiche ispirate alla diffidenza verso lo straniero, e che avevano come scopo quello di rendere gli italiani “padroni a casa propria” !
In questo rincorrere l’emigrazione italiana si leggono illusioni e pregiudizi. L’illusione ricorrente è che gli italiani all’estero possano essere una sorta di ‘quinta colonna’ degli interessi nazionali. La storia insegna, semmai, che posti di fronte alla scelta tra la fedeltà al paese d’origine o a quello che aveva dato loro una nuova vita (es. gli italoamericani nella Seconda Guerra Mondiale) gli emigrati non hanno mai avuto dubbi ed hanno scelto il paese d’adozione. Il modo quasi schifiltoso con cui Madame Carla Bruni-Sarkozy ha parlato della sua scelta di non essere più italiana ben riassume i complessi di superiorità degli émigrés nei confronti del loro ex-paese.
I pregiudizi nascono dal complesso di inferiorità ovvero dai sensi di colpa nei confronti degli emigrati. Per alcuni infatti, c’è una gerarchia di valore tra chi è rimasto e chi è partito, considerati questi ultimi i migliori e i più coraggiosi (pregiudizio ricorrente, per esempio, nei confronti della recente emigrazione accademica). I sensi di colpa vogliono che si ripari nei confronti di chi è stato “costretto” ad emigrare.
Le leggi non nascono nel vuoto, naturalmente, ed occorre tenere presenti questi fattori psicologici e sociali. Come scrive la Zincone: “la cifra peculiare che informa l’azione dello stato Italiano nelle sue politiche di cittadinanza è da ricercare nelle categorie del sentimento e del familismo”.
Occorre invece considerare razionalmente il problema, dal punto di vista economico e politico. Il nostro paese deve fare appello alle forze che lavorano e vivono in Italia, deve guadagnarsi la loro fiducia e la loro fedeltà. Deve anche, per un elementare senso di giustizia, far collimare diritti e doveri. Nell’attuale assetto, gli italiani all’estero hanno troppi diritti e pochi doveri, mentre agli stranieri in Italia non sono corrisposti diritti proporzionali al loro contributo. Vogliamo ricordarlo che essendo appena il 5% della popolazione producono il 10% del PIL?
Sarebbe dunque auspicabile introdurre norme che risolvano il rapporto di cittadinanza con coloro che sono ormai stabilmente all’estero. Soprattutto nei confronti di coloro che si sono stabiliti negli altri paesi dell’Unione Europea e che ne hanno acquisito volontariamente la nazionalità, occorrerebbe dare piena attuazione alla Convenzione Europea di Strasburgo contro la doppia cittadinanza. Come scrive la Zincone: “i cittadini dell’Unione Europea, in base al Trattato di Amsterdam possono risiedere e lavorare liberamente in un altro paese dell’Unione senza naturalizzarsi. Se e quando ne diventano cittadini è perché sono motivati da emozioni e ragioni civili: perché questo è un modo di manifestare il proprio legame culturale ed affettivo con la nuova patria, perché così possono votare alle elezioni politiche” (pag. 19).
Perché dunque queste persone dovrebbero rimanere cittadine italiane? Se una va a vivere e lavorare in Germania, impara il Tedesco, sposa un Tedesco, compra casa in Germania, paga le tasse in Germania, e senza necessità, volontariamente, acquista la cittadinanza tedesca, che cos’è? Una Tedesca. Magari una Tedesca che predilige gli spaghetti ai crauti, ma non si vede perché la nostra comunità nazionale debba farsene più carico, perché i contribuenti italiani debbano pagarle dei servizi, perché il suo voto debba essere determinante nella decisione della politica nazionale, perché essa possa concorrere agli incarichi pubblici. Vaja con diòs, senza rancore.
L'Italia non è una prigione, e la scelta di andarsene è assolutamente legittima, e moralmente neutra: ma essa non può essere premiata, soprattutto a scapito di coloro che sul nostro paese hanno scommesso l'esistenza. L'Italia deve quindi riconoscere come suoi cittadini a pieno titolo coloro che contribuiscono, con il loro lavoro, alla produzione del benessere nazionale, cioè i milioni di stranieri immigrati. A costoro, a precise condizioni, ed entro tempi ragionevoli dovrebbe essere concessa, su richiesta ed evitando qualunque automatismo, la naturalizzazione.
Chi mai inviterebbe all'assemblea di condominio, a decidere delle spese e delle azioni comuni, uno che abbia venduto l'appartamento e cambiato quartiere? Una casa è di chi vi abita e contribuisce a mantenerla.
Così l'Italia appartiene a chi ci vive. Al diritto arcaico del suolo e del sangue occorre sostituire il diritto del lavoro e del sudore.
Il sangue È acqua.
====
Vedi anche:
Padroni del nostro futuro
Barbagli ed abbagli
Il sangue, dunque, sostanza tra il biologico e lo spirituale, che dovrebbe portare con sé chissà quali richiami ancestrali, definire rapporti indissolubili e permanenti. Ha ancora un senso parlare di legami di sangue, nel nostro tempo? Il trionfo di Barack Obama infrange l’ultima barriera razziale all’interno di quello che pure è il paese più multietnico del pianeta. L’evidenza ci dimostra che i popoli più dinamici sono proprio quelli che si sono liberati di ogni criterio etnico – tribale, e che hanno acquisito la capacità di richiamare le persone più brillanti, a prescindere dalla loro nascita.
Non è un caso che la leggenda della fondazione di Roma racconti che Romolo popolò la sua città raccogliendo sbandati di ogni genere, accogliendoli sulla spianata dedicata al dio Asilo (Asylum), quella che oggi è la Piazza del Campidoglio. La città che nasce in questo modo “americano” rinnega i suoi legami tribali con Albalonga dichiarandole guerra, e sarà capitale di un impero che - come ci racconta Andrea Giardina in "L'Italia romana. Storie di un'identità incompiuta" (Laterza) - era singolarmente immune dal razzismo.
I romani, inoltre, agitati da una profonda diffidenza verso la filiazione naturale (un po' perché ‘pater semper incertus’, un po' perché genitori anaffettivi com'erano, i loro figli potevano apparire loro degli estranei) inventarono l’adozione, un rapporto di filiazione giuridica. Con l’adozione una persona adulta riconosceva in un altro adulto le sue qualità e lo chiamava figlio. La familia romana non si identificava per la continuità della linea di sangue, ma attraverso il patrimonio, finanziario ed ideale, che si tramandava tra i discendenti, naturali o adottati.
Insomma, la romanità costituisce per la prima volta un sistema di fedeltà e di legami che prescinde dal sangue.
La rivoluzione francese continuerà l’opera. La “Nazione” sostituisce il Re nella fedeltà dei cittadini, afferma i suoi diritti in antitesi al diritto dinastico del sangue, in base al quale i re avevano potuto smembrare e scambiarsi territori, e, come la familia romana, diventa un patrimonio di idee e di valori nel quale ci si può identificare a prescindere dalla nascita. La Francia, dal primo Ottocento a metà Novecento, riesce così ad attrarre ed integrare forze vive dall'estero nel suo tessuto sociale.
La storia insegna che la grandezza di un paese è data dalla sua capacità di accoglienza. Gli ebrei, cacciati dalla Spagna, furono accolti in Olanda. Lo stesso evento segnò l’inizio della decadenza della Spagna, e del Secolo d’Oro olandese.
Anche in Italia, allora, paese che è diventato di immigrazione senza mai aver veramente cessato di essere tributario dell’emigrazione, sarebbe il caso di porsi una domanda: chi è un Italiano, e chi non lo è?
 Nell'esaminare la questione debbo prima onestamente confessare la mia parzialità. Sono fiero di essere italiano, ma molto meno fiero di avere certi compatrioti. Quando il treno che mi porta al lavoro recita quella litania di borgate romane dai nomi improbabili (Ostia Antica - Acilia - Dragona - Vitinia - CasalBernocchi) non riesco a sentire alcuna affinità spirituale od etnica con certi truci soggetti che colà vivono. Mi fanno paura, e basta. Mentre invece provo viva simpatia per quei giovani sani e forti che hanno attraversato il mare e i deserti pur di venire qui a lavorare, e che sono d'esempio a una società troppo pigra e soddisfatta di sé.
Nell'esaminare la questione debbo prima onestamente confessare la mia parzialità. Sono fiero di essere italiano, ma molto meno fiero di avere certi compatrioti. Quando il treno che mi porta al lavoro recita quella litania di borgate romane dai nomi improbabili (Ostia Antica - Acilia - Dragona - Vitinia - CasalBernocchi) non riesco a sentire alcuna affinità spirituale od etnica con certi truci soggetti che colà vivono. Mi fanno paura, e basta. Mentre invece provo viva simpatia per quei giovani sani e forti che hanno attraversato il mare e i deserti pur di venire qui a lavorare, e che sono d'esempio a una società troppo pigra e soddisfatta di sé.Sul tema dei diritti di cittadinanza, sono in libreria, per i tipi di Laterza, due interessanti studi: “Cittadinanze. Appartenenza e diritti nella società dell'immigrazione” di Laura Zanfrini, e “Familismo Legale. Come (non) diventare italiani” di Giovanna Zincone.
La più recente legge italiana sulla cittadinanza, L. n° 91 del 1992, rafforza il criterio dello ius sanguinis, rende più facile acquisire la cittadinanza ai discendenti di emigrati italiani (dai 30 ai 60 milioni), e ben più difficile agli stranieri. È una legge etnica. Dunque razzista.
È ovviamente impossibile che la comunità dei residenti e la comunità dei nazionali coincidano perfettamente. Ma la legge del 1992 anziché tendere a collimare le due cose, ha introdotto un fortissimo scollamento tra chi è ‘in Italia’ e chi è ‘Italiano’. Una legge di retroguardia, mirata a rincorrere l’emigrazione italiana, piuttosto che ad integrare i nuovi arrivati. Il risultato è stato, come ho già scritto, di creare all’interno del paese una comunità di meteci, persone di serie B, discriminate non solo rispetto ai cittadini residenti, ma pure rispetto agli extracomunitari di lontane origini italiane che vivono tuttora all’estero.
Inoltre, la nuova legge elettorale (con le modifiche costituzionali che, caso unico al mondo, hanno suddiviso l’intero pianeta in circoscrizioni elettorali nazionali) ha attribuito un peso talvolta determinante al voto degli italiani all’estero. Insomma, degli affari italiani, delle scelte politiche, economiche, dall’allocazione della spesa pubblica, possono essere arbitre persone che hanno lasciato l’Italia, ovvero non vi hanno mai messo piede, e che comunque non vi lavorano, non vi producono e non vi pagano le tasse. Risultato paradossale di politiche ispirate alla diffidenza verso lo straniero, e che avevano come scopo quello di rendere gli italiani “padroni a casa propria” !
In questo rincorrere l’emigrazione italiana si leggono illusioni e pregiudizi. L’illusione ricorrente è che gli italiani all’estero possano essere una sorta di ‘quinta colonna’ degli interessi nazionali. La storia insegna, semmai, che posti di fronte alla scelta tra la fedeltà al paese d’origine o a quello che aveva dato loro una nuova vita (es. gli italoamericani nella Seconda Guerra Mondiale) gli emigrati non hanno mai avuto dubbi ed hanno scelto il paese d’adozione. Il modo quasi schifiltoso con cui Madame Carla Bruni-Sarkozy ha parlato della sua scelta di non essere più italiana ben riassume i complessi di superiorità degli émigrés nei confronti del loro ex-paese.
I pregiudizi nascono dal complesso di inferiorità ovvero dai sensi di colpa nei confronti degli emigrati. Per alcuni infatti, c’è una gerarchia di valore tra chi è rimasto e chi è partito, considerati questi ultimi i migliori e i più coraggiosi (pregiudizio ricorrente, per esempio, nei confronti della recente emigrazione accademica). I sensi di colpa vogliono che si ripari nei confronti di chi è stato “costretto” ad emigrare.
Le leggi non nascono nel vuoto, naturalmente, ed occorre tenere presenti questi fattori psicologici e sociali. Come scrive la Zincone: “la cifra peculiare che informa l’azione dello stato Italiano nelle sue politiche di cittadinanza è da ricercare nelle categorie del sentimento e del familismo”.
Occorre invece considerare razionalmente il problema, dal punto di vista economico e politico. Il nostro paese deve fare appello alle forze che lavorano e vivono in Italia, deve guadagnarsi la loro fiducia e la loro fedeltà. Deve anche, per un elementare senso di giustizia, far collimare diritti e doveri. Nell’attuale assetto, gli italiani all’estero hanno troppi diritti e pochi doveri, mentre agli stranieri in Italia non sono corrisposti diritti proporzionali al loro contributo. Vogliamo ricordarlo che essendo appena il 5% della popolazione producono il 10% del PIL?
Sarebbe dunque auspicabile introdurre norme che risolvano il rapporto di cittadinanza con coloro che sono ormai stabilmente all’estero. Soprattutto nei confronti di coloro che si sono stabiliti negli altri paesi dell’Unione Europea e che ne hanno acquisito volontariamente la nazionalità, occorrerebbe dare piena attuazione alla Convenzione Europea di Strasburgo contro la doppia cittadinanza. Come scrive la Zincone: “i cittadini dell’Unione Europea, in base al Trattato di Amsterdam possono risiedere e lavorare liberamente in un altro paese dell’Unione senza naturalizzarsi. Se e quando ne diventano cittadini è perché sono motivati da emozioni e ragioni civili: perché questo è un modo di manifestare il proprio legame culturale ed affettivo con la nuova patria, perché così possono votare alle elezioni politiche” (pag. 19).
Perché dunque queste persone dovrebbero rimanere cittadine italiane? Se una va a vivere e lavorare in Germania, impara il Tedesco, sposa un Tedesco, compra casa in Germania, paga le tasse in Germania, e senza necessità, volontariamente, acquista la cittadinanza tedesca, che cos’è? Una Tedesca. Magari una Tedesca che predilige gli spaghetti ai crauti, ma non si vede perché la nostra comunità nazionale debba farsene più carico, perché i contribuenti italiani debbano pagarle dei servizi, perché il suo voto debba essere determinante nella decisione della politica nazionale, perché essa possa concorrere agli incarichi pubblici. Vaja con diòs, senza rancore.
L'Italia non è una prigione, e la scelta di andarsene è assolutamente legittima, e moralmente neutra: ma essa non può essere premiata, soprattutto a scapito di coloro che sul nostro paese hanno scommesso l'esistenza. L'Italia deve quindi riconoscere come suoi cittadini a pieno titolo coloro che contribuiscono, con il loro lavoro, alla produzione del benessere nazionale, cioè i milioni di stranieri immigrati. A costoro, a precise condizioni, ed entro tempi ragionevoli dovrebbe essere concessa, su richiesta ed evitando qualunque automatismo, la naturalizzazione.
Chi mai inviterebbe all'assemblea di condominio, a decidere delle spese e delle azioni comuni, uno che abbia venduto l'appartamento e cambiato quartiere? Una casa è di chi vi abita e contribuisce a mantenerla.
Così l'Italia appartiene a chi ci vive. Al diritto arcaico del suolo e del sangue occorre sostituire il diritto del lavoro e del sudore.
Il sangue È acqua.
====
Vedi anche:
Padroni del nostro futuro
Barbagli ed abbagli
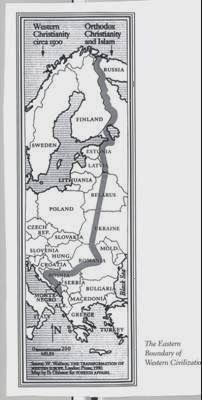
Column brillante, come al solito, ma non molto condivisibile. Non ha gran senso paragonare l'esperienza europea con quella nordamericana. Sotto molti profili. L'Europa come noi la conosciamo è il portato della vittoria storica dello Stato-nazione monoetnico. Che forse non si è ancora del tutto completata, come prova l'attuale tendenza alla frammentazione. L'America, fortuna sua, è nata dal principio esattamente opposto. Come speranza per i marginali d'Europa e di tante altre aree. L'immigrazione nel nostro Continente sta generando insicurezza sociale e reazioni di rigetto, che sono tanto più forti in quanto i nostri ospiti sono spesso latori di identità culturali non assimilabili. Non è quindi facile assumere certe posizioni. Perchè, da noi, l'assalto migratorio è più probabile che incubi sommosse sociali che non sviluppo e crescita. GD
RispondiEliminaVeramente il paragone lo facevo con l’Antica Roma… e se hai letto bene, dimostro che ci sono stati esempi anche in Europa di società accoglienti. Di converso, l’America, pur se in linea di principio così tollerante, solo un mese fa è riuscita a venire a patti con l’idea di avere come presidente un non bianco.
RispondiEliminaAmerica ed Europa non sono poi così lontane e nettamente distinte: la rinascita britannica, lo sai bene, è stata fondata sul favore all’immigrazione, e Londra è oggi la città europea più simile a New York per cosmopolitismo. La Francia ha per presidente il figlio di immigrati ungheresi. I grandi paesi imperiali di un tempo (Uk, Francia, Olanda, Portogallo), sono tutti fieramente multietnici.
La “vittoria storica dello Stato monoetnico”, come dici tu, è stata pagata a prezzo di milioni di morti, e di spaventose pulizie etniche, da ultimo nelle guerre balcaniche. E si tratta di una vittoria comunque effimera, visto che i flussi migratori già scompaginano le carte.
Sul fatto che “insicurezza sociale e reazioni di rigetto” siano l’effetto e non la causa dell’essere i nostri ospiti “spesso latori di identità culturali non assimilabili”, non sarei tanto sicuro. La storia delle emigrazioni dimostra che gli emigrati si spogliano tanto più volentieri e facilmente della loro identità, quanto più trovano un terreno favorevole ed integrante. Mentre il riflesso identitario e il rifiuto all’assimilazione nascono da un atteggiamento ostile che porta gli immigrati a rinchiudersi in ghetti e a parlare solo tra loro.
Per esempio, gli italiani in America si rivolsero naturalmente alla Mafia, perché non accettati dalla società anglosassone e protestante dell’epoca, che nemmeno li considerava bianchi. In Australia, gli Italiani vennero dispersi ed anglicizzati, e la Mafia lì non c’è.
Rifletti, del resto: perché chi lascia un paese che non gli ha dato nulla, dovrebbe mantenere sentimenti di gratitudine e affetto verso dei esso e non verso quello che gli ha offerto delle opportunità?
La nostra incapacità di integrare gli stranieri deriva dalla nostra insicura identità nazionale, che rafforza anziché affievolire le identità dei nuovi arrivati. È paradossale perciò che il partito che più ha fatto per affossare il sentimento nazionale, cioè la Lega, poi lo riscopra strumentalmente in funzione anti immigrati.
Rimane dunque insoluto il problema – sul quale non dici niente - di ridefinire i confini della nostra comunità nazionale facendoli coincidere il più possibile con la comunità dei residenti.
Oggi ci sono troppi italo-qualcosaltro all’estero cui una legislazione incosciente ha regalato il diritto di voto senza contropartite. Sarebbe stato comprensibile, per esempio stimolare una immigrazione di ritorno dall’Argentina dei discendenti di italiani che vivono colà. Invece gli argentini che hanno avuto il passaporto italiano sono emigrati – essendo ormai cittadini europei - direttamente in Spagna, paese del quale conoscono la lingua.
Inoltre tanti italiani hanno manifestato inequivocabilmente la loro volontà di essere cittadini di un altro paese europeo, e non ha senso che mantengano la cittadinanza italiana. Alla fine, evviva Carla Bruni, che è diventata francese, ed ha rinunciato al nostro passaporto. La doppia cittadinanza, come l’adulterio, è un mantenere il piede in due staffe. Costringere costoro a scegliere tra troppe lealtà sarebbe un gesto di chiarezza. Soprattutto perché il loro voto conta, spesso in modo determinante.
Lo scollamento tra cittadinanza e comunità dei residenti significa tra l’altro il venire meno del nesso democratico taxation / representation : così gli italiani all’estero hanno diritti politici ma non pagano tasse, gli stranieri in Italia pagano tasse ma non hanno diritti politici.
È giusto? È logico? È economicamente produttivo? Politicamente sostenibile?
Rispondi a questo, se puoi.
A forza di ululare allarmi, il messaggio entra nelle case e nelle menti di tutti noi. Una cosa è l'incidenza dell'immigrazione, una cosa è la persistenza di un'ampia immigrazione clandestina, bel altro la legittimazione dei diritti di cittadinanza in capo agli immigrati a pieno titolo inseriti nel contesto civile italiano.
RispondiEliminaSolo la classe politica più demagogicamente demente della storia italica poteva spingere di continuo sulle paure e le insicurezze, scatenando, se non astio nei confronti del diverso, quanto meno un'atomizzazione sociale esasperata, la fine di quei legami solidaristici minimali tra parenti, colleghi, vicini che erano stati sempre un punto forte (ovviamente, quando ciò non sfociava in familismo amorale) del tessuto connettivo del Paese, sostituiti da diffidenza, chiusura, astio.
Solamente l'indicibile grettezza di costoro può aver impostato per più di tre lustri la concezione dell'immigrato come quella di mero prestatore d'opera, di braccia da fatica, roba che si ricorda solo negli Stati del Sud degli Usa prima della guerra civile. Braccia da fatica che devono rimanere assenti dal consesso civile, chè il loro ruolo è solo quello di lavorare, e guai a chiedere il riconoscimento della loro esistenza come uomini.
Solamente la sconcia ottusità di costoro e dei loro microfoni propagandistici può supporre di ignorare una realtà che è sotto gli occhi di tutti, ossia che la metà o quasi delle classi di scuola dell'obbligo è di bambini figli di genitori stranieri, nati in Italia ma non cittadini, e comunque pienamente italiani per lingua, dialetti, cadenze, costumi, abitudini, indole e persino pantaloni a vita bassissima.
Una classe politica appena appena lungimirante dovrebbe chiedersi non se, ma quando e quanto esploderà la convivenza se non si procede nel più breve tempo possibile e nel miglior modo possibile ad una integrazione. Pensano forse che i romeni nati e cresciuti in Italia tra una decina d'anni si accontenteranno di fare i manovali in nero? Che i figli dei cileni puliranno il deretano a vecchiette abbandonate dai figli? Che i figli degli egiziani faranno pizze e kabab? Che i figli degli indiani venderanno accendini ai semafori e rose riverniciate nei ristoranti al sabato sera?
O si renderanno conto che dei giovani uomini, maggiorenni, il cui cursus studiorum è stato integralmente svolto sotto il segno dei programmi ministeriali nazionali, saranno dei minus habentes quando si tratterà di avere un passaporto, un lavoro, aprire un conto corrente, partecipare ad un concorso pubblico? E che, soprattutto, non potranno in alcun modo riconoscere le istituzioni statali perchè all'elezione dei rappresentanti del popolo, alla possibilità (assai teorica, va da sè) di partecipare, essi non posso in alcun modo concorrere?
Se pensiamo che questa sia una situazione grave, vuol dire che non abbiamo alcuna idea di ciò che sarà davvero tra 10-12 anni. E svegliarsi allora chiedendosi come rimediare sarà del tutto inutile, perchè il danno sarà stato irreversibile.
L’atteggiamento verso l’immigrazione è la cartina di tornasole della nostra distanza dall’Europa.
RispondiEliminaL’Italia, paese poco meritocratico per natura, non ha da offrire la possibilità di evolversi a chi abbia doti e talenti da sfruttare. Questo influenza anche la qualità della nostra immigrazione: noi attiriamo lavoratori non specializzati, non investitori, non creativi, non giovani accademici.
Per esempio: dopo l’adesione alla UE, i rumeni che avevano un titolo di studio sono andati in Francia ed Inghilterra. Quelli senza titoli di studio sono venuti in Italia, a fare gli operai generici e i muratori (e purtroppo anche ad infoltire la criminalità se la metà dei detenuti nelle carceri romane, oggi, è di nazionalità rumena).
Io chiamo razzismo anche questa solidarietà pelosa (che alligna assai bene a sinistra e nel mondo cattolico) che accetta ed accoglie lo straniero solo se ed in quanto è “diverso”, “marginale”, “ultimo”. Soprattutto povero e proletario. Non si è detto per anni che dobbiamo accettare gli immigrati in quanto “vengono a fare lavori che gli italiani non vogliono più fare”? Il che significa: evviva lo straniero fintantoché si accontenta di fare il raccoglitore di pomodori, il lavavetri, la badante!!! Ma guai a pensare che possa aspirare al nostro stesso livello di vita, e farci concorrenza nelle professioni, diventare anche lui – orrore! – un borghese.
Così, ad esempio, la mia compagna ha dovuto – benché plurilaureata con lode – rifare tutti gli studi e conseguire (brillantemente) di nuovo la laurea in Italia. Rimpiangendo amaramente di esserci mai venuta.
Chi ha voglia di migliorare la propria condizione non viene in Italia: va a Londra – sempre più cosmopolita - a Parigi, dove il governo di Sarkozy (lui stesso figlio di immigrati) conta già due donne africane.
La mia ex nigeriana, già immigrata clandestina, ha avuto dal governo olandese opportunità – di inserimento, di integrazione, di studio - che in Italia non si sarebbe assolutamente sognata.
L’immigrazione è una forza travolgente, un movimento di risveglio di interi continenti: l’Europa avanzata prospera sull’apporto di nuove e giovani forze, le accoglie, le include, profitta della loro linfa vitale, e offre loro un quadro in cui esprimersi al meglio.
Di fronte a questo grandioso fenomeno, pensiamo davvero di essere così generosi, quando tutto ciò che sappiamo offrire sono lavoretti di mera sussistenza ai margini della legalità? Ma quanto siamo magnanimi, davvero!...
Risposte ed ulteriori commenti generano in me ulteriori perplessità. Mi pare che guardiate all'Italia ed all'Europa non per ciò che sono come per come voi vorreste che fossero. Vecchia diatriba, quella tra realisti ed idealisti, che trova qui una ulteriore declinazione. Intanto: attiriamo poca manodopera specializzata e pochi cervelli per la semplice ragione che il sistema Italia di per sè genera posizioni insufficienti già per i nostri cervelli: che infatti alimentano un'emigrazione d'élite. Poi, sull'America: è molto difficile per un musulmano entrarvi. Lo ha notato anche Fukuyama. Verso gli States vanno in tanti, ma a dispetto di questo solo l'1% degli americani è musulmano. Quanto a Roma: i romani crearono un impero universale, inglobando popoli diversi, cooptandone gli dei ed infine integrandoli. Questa è una strategia possibile solo finchè sulla scena non irrompono i monoteismi. Quando arrivano i monoteismi, non c'è più spazio: perchè si tratta di far convivere sullo stesso terreno due verità che si negano. Non ci sono le condizioni per ripetere l'esperimento. Infine, il revival identitario: è un fenomeno che riguarda tutti i Paesi che ospitano comunità immigrate musulmane, a prescindere dal livello della loro integrazione. E' un riflesso della crisi delle ideologie della Guerra Fredda e del cosiddetto Ritorno di Dio nella storia. Che prepara, a mio modesto avviso, la nascita di partiti islamici nel nostro Continente. GD
RispondiEliminaBah, non vado cercando soluzioni ideali o esprimere auspici su come vorrei che fosse. Mi basterebbe che si tentasse di scongiurare una catastrofe certa, ossia come auspicherei che NON fosse.
RispondiEliminaDi sicuro, il fatto che si attiri spesso immigrazione poco qualificata è logica conseguenza della propensione all'esclusività piuttosto che all'inclusività, ed in questo dice benissimo Dario quando menziona questa pelosa vena caritatevole che concepisce l'immigrato come naturale predestinato a collocarsi alla base della piramide sociale e guai se osa rialzarsi.
Le valenze religiose non mi preoccupano così tanto. Certo, non amo l'idea di uno zoccolo duro di ferventi musulmani arruolabili magari a qualche casa jihadista, mi pare ovvio. Ma è proprio questo che, a maggior ragione, sollecita l'inclusione, invece di respingerne l'idea.
Costoro fanno figli che del Paese di origine conoscono poco o nulla; fanno figli che crescono italiani e con modi di pensare italiani. Alla lunga, la ribellione all'ottusità maschilista e retrograda (ben più che religiosa) dei genitori sarà un potente fattore di annacquamento delle pulsioni tendenti al fanatismo.
E allora, per una Hina che ieri è stata brutalmente uccisa dal gran consiglio dei maschi di famiglia per punirne il comportamento immorale, domani ci saranno centomila Fatima che cresceranno come una qualsiasi Samantha. E allora, che risposta dovremmo dare loro? Dovremmo dire che sono e restano straniere, figli di immigrati, che se vogliono diventare italiane possono farlo solo tra i 18 e i 19 anni, meglio ancora se prima costrette ad andare nel loro (!?!) Paese per poi rientrare? Se questa rimanesse la capacità di includere, per quale motivo allora trovare un motivo di assimilazione, di uguaglianza coi coetanei, di appartenenza al Paese in cui si è nati e soprattutto cresciuti e che si scopre all'improvviso ottusamente e burocraticamente respingente?
Dario, per pietà, leva quest'obbligo di accoppiarsi a un profilo, un url, un account di google, un checchessia! Mi irrita auto-qualificarmi come anonimo.
RispondiEliminaNandokan
Veramente è proprio quello che ho detto: la qualità della nostra immigrazione è selezionata dal nostro sistema economico. Cioè è 'pull'.
RispondiEliminaPeraltro c'è anche una immigrazione "push", e non sorprende che sia fatta di mussulmani, visto che confiniamo con quel mondo.
In America è più difficile arrivare con le barchette dall'Africa, no?
Ma ridurre l'immigrazione al problema islamico mi pare riduttivo.
Noi quando la Lettonia, la Polonia, la Lituania, hanno aderito alla UE le abbiamo chiuso le porte in faccia, con la moratoria sulla libertà di movimento.
E così le più belle ragazze d'Europa sono andate in Irlanda e in UK.
Continuiamo così, facciamoci del male...
Non è colpa mia se è così complicato postare commenti, è Blogger che è fatto così e io non ci posso fare niente. Migliorerà.
RispondiEliminaComunque si può sempre scegliere la combinazione Nome/URL e riempire solo la prima casella, come ora ho fatto io.
Oppure 'anonimo' ma firmarsi in calce.
I bow before arguments. Yet, there are some other conditionalities... So many others.
RispondiEliminaLet's take the free movement. It's not pure and simple, but free movement for workers. Therefore economics. Oh, yeah, and states can chose not to apply it for some years.
Why does one emigrate / immigrate? For he/she loves one country better than the other? Because he/she loves the weather better? Or is it for some other reason? And why do states "adopt" immigrants? For pure, unconditional love? Or for the added value the immigrants bring to their society?
Yeah, lots of questions, few answers.
Here's an answer. I bet a footballer stands a better chance of naturalisation than a construction worker.
There you have it.
Doest thou wish for an outrageous idea? Give up the citizenship concept and apply human rights round the globe.
Le motivazioni storiche o ideali che avallano la necessità storica dei fenomeni immigratori sono state esaurientemente e brillantemente riassunte da Dario.
RispondiEliminaAggiungo un’osservazione empirica: la capacità di un individuo di concepire l’integrazione è direttamente proporzionale al suo livello culturale. Lo intuii ai tempi degli studi universitari, notando come i colleghi stranieri, allora per la maggior parte di colore, facessero naturalmente parte della comunità studentesca. Ne ho avuto continua conferma, ogni volta che ho visto professare il razzismo, da parte di persone che più ragionevolmente avrebbero dovuto subirlo.
Una considerazione mi pare invece fondamentale, ora che lo spettro della recessione aleggia sulle nostre teste. Se, ad oggi, gli stranieri rappresentano il 10% del nostro PIL, ne costituiscono la parte attiva, il lievito in fermento.
Sono venuti in Italia per produrre (ed una crisi, a mio vedere, si scongiura aumentando la produzione, altro che i consumi), mentre i nostri capitani d’industria hanno preferito, delocalizzando all’estero, affamare i nostri operai pur di mantenere alti i loro utili.
Dopo aver consentito alle nostre imprese di prosperare, accettando paghe da fame e condizioni di lavoro inumane, oggi sono gli strnieri i nuovi imprenditori, gli artigiani, i costruttori (e a breve mi attendo di vedere sul mercato i commercialisti russi, gli ingegneri indiani, gli avvocati tunisini, mentre già non è raro vedere negli ospedali medici africani), mantenendo viva un’economia che, se fosse per i nostri “fannulloni”, sarebbe già al collasso.
Non è lontano il momento in cui, chiuso l’accesso al posto pubblico e terminati i posti disponibili nelle banche, i nostri giovani dovranno riporre nell’armadio l’abito e la cravatta acquistati per il lavoro e saranno costretti a piegare la schiena nei cantieri o nelle officine, sotto i nuovi padroni rumeni od egiziani; e stiano tranquilli che chi è sopravvissuto dormendo nelle baracche e mangiando cibo per cani non sarà molto tenero con i figli di papà.
Se pur dovesse essere poi vero il teorema del nostro premier, saranno pur sempre gli stranieri a tenere alti i consumi. Dopo gli anni nei tuguri, ambiscono a possedere casa, prima bandiera dell’emancipazione (tenendo fra l’altro vivo il mercato immobiliare nei piccoli centri, che senza di loro sarebbero stati destinati all’estinzione); dopo la fame, riempiono i carrelli nei supermercati; sognano i nostri stessi status symbol, l’auto, la moda; sono abbagliati dalle meraviglie della tecnologia e fanno incetta di telefonini e televisori al plasma.
Teniamoceli stretti gli stranieri, sono loro che possono salvare la nostra economia.
Il presidente rumeno è venuto recentemente a Roma, per richiamare in patria i suoi connazionali: speriamo che non gli diano ascolto.
ROMA MULTIETNICA MEGLIO DI ATENE
RispondiEliminaUn mito segnato dalla commistione e integrazione di stirpi
Eva Cantarella
(Corriere della Sera 19 febbraio 2010, Pagina 51)
Roma, 40 d.C.: l' imperatore Claudio propone di concedere ad alcuni Galli la possibilità di essere magistrati o senatori. L' opposizione insorge: «Roma non ha bisogno di stranieri per ricoprire cariche di governo». Ma alla fine la proposta viene accettata. Nel racconto di Tacito, dopo il seguente discorso: «A quale ragione si deve la rovina degli ateniesi e degli spartani se non alla loro ostinazione nel non accogliere gli stranieri? Romolo invece fu così saggio da saper trattare nello stesso giorno gli stessi popoli da nemici e da cittadini. Su di noi hanno regnato degli stranieri, i figli dei nostri ex schiavi possono diventare magistrati. La storia di Roma ne ha dato molti esempi...». Non è questo, ovviamente, il momento di discutere quale fu la causa della rovina dei greci, ma certamente il loro rapporto con gli altri è stato diverso da quello dei romani. A dimostrarlo, in primo luogo, stanno i miti di fondazione delle loro città: quei miti, vale a dire, attraverso i quali le città si raccontavano, dandosi un' identità e definendosi, appunto, nel loro rapporto con gli altri. Gli ateniesi, secondo il mito, erano nati dal suolo patrio, fecondato dal seme di Efesto, finito per terra dopo un vano tentativo del dio di possedere la vergine Atena. Erano autoctoni dunque, gli ateniesi, e tali volevano restare: non volevano essere «contaminati» da altri popoli. Non solo nel mito, anche nella realtà. A darne una prova sta la loro politica verso gli stranieri che risiedevano stabilmente nella città: i famosi «meteci» (da metoikein, vivere insieme). Difficile dire quanti fossero. Secondo il censimento voluto da Demetrio Falereo, tra il 317 e il 307 a.C. erano circa la metà dei cittadini. E la loro presenza, trattandosi prevalentemente di commercianti, era una risorsa fondamentale per l' economia ateniese. Ma Atene non concesse loro diritto di cittadinanza. Si limitò ad accoglierli, a condizione che entro un mese dall' arrivo si registrassero nelle apposite liste. Se non lo facevano potevano subire la confisca dei beni ed essere venduti come schiavi: sanzioni forti, capaci di garantire che non ci fossero molti sans papier. Chi si registrava, invece, acquistava il diritto di residenza, a condizione che un cittadino garantisse per lui, e diventava un contribuente, pagando una speciale tassa (il metoikion). Ma non poteva possedere terre né immobili; non poteva sposare un' ateniese; la sua uccisione era punita meno di quella di un ateniese e in giudizio poteva testimoniare solo sotto tortura (come gli schiavi). Una scelta chiara, molto diversa da quella dei romani, il cui carattere etnicamente composito era celebrato dal mito di fondazione, che riconduceva la nascita della città al matrimonio tra l' eroe troiano Enea e Lavinia, figlia del re Latino. In Romolo, che da quell' unione discendeva, scorreva dunque sangue laziale e sangue troiano. La leggenda raccontava inoltre che per popolare la città egli aveva aperto un asilum nel quale aveva offerto rifugio a tutti gli stranieri che chiedevano ospitalità e protezione, e che le prime mogli dei romani erano Sabine (inutile ricordare il celebre ratto), come il re Tito Tazio. Il mito di Roma, insomma, racconta una città nella quale si aveva da sempre commistione e integrazione di stirpi, e in cui all' apertura etnica si accompagnava l' apertura sociale: gli schiavi liberati, che ad Atene diventano meteci, con la libertà acquistavano anche la cittadinanza romana. Il dato etnico era meno importante di quello politico.
(segue...)
(... prosegue)
RispondiEliminaCome scrive Polibio, i romani erano più pronti di ogni altro popolo ad adottare costumi stranieri, se migliori dei loro. Simmaco ricorda che avevano adottato le armi dei Sanniti, le insegne degli Etruschi e le leggi dei legislatori greci, Licurgo e Solone. Ma la prova migliore della loro apertura viene dalla politica della cittadinanza in età imperiale. Prima che Caracalla, nel 212 d.C., concedesse la cittadinanza a tutti, nel 198 d.C. divenne imperatore, con il nome di Settimio Severo, un semita di Leptis Magna, che parlava con forte accento punico. E dopo il 212 erano romani tutti gli abitanti dello sterminato impero. Non è inutile, oggi, ricordare i miti che parlano della commistione e della integrazione dei popoli come di una ricchezza, e pensare che vi sono stati momenti in cui così è stato.
Sarebbe bello che oggi uno straniero potesse dire, del Paese che lo ha accolto, quel che disse di Roma, nel IV secolo d.C., il poeta Rutilio Namaziano. Costretto a tornare nella Gallia, dove era nato, devastata dall' invasione dei Vandali, Rutilio (nella traduzione di Giosuè Carducci) salutò Roma con queste parole: «Desti una patria ai popoli dispersi in cento luoghi /... del tuo diritto ai sudditi mentre il consorzio appresti / di tutto il mondo una città facesti».
Anticipiamo qui sopra l' intervento di Eva Cantarella al convegno che si svolge oggi a Firenze sulla «Terza identità. Da Obama a Rosarno fino al Vangelo secondo Luca» (Palazzo Medici Riccardi, ore 9.30 la sessione del mattino e 15.30 quella del pomeriggio). Sul tema delle migrazioni come fenomeno fondante delle civiltà, sui processi di globalizzazione e sulle politiche migratorie, si confrontano tra gli altri Luigi Luca Cavalli Sforza, Enrico Chiavacci, Massimo Livi Bacci, Enrico Deaglio. Il convegno è organizzato dalla Provincia di Firenze e dal Gabinetto Vieusseux.