Se io fossi il Presidente
 Ho visto al cinema il film “L’uomo dell’anno” con Robin Williams. Williams interpreta Tom Dobbs, un popolarissimo comico che, nel corso del suo talk show quotidiano prende in giro i politici e si fa portavoce di una nazione delusa ed esasperata, che non crede più nella partecipazione democratica. Così il pubblico gli chiede di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti.
Ho visto al cinema il film “L’uomo dell’anno” con Robin Williams. Williams interpreta Tom Dobbs, un popolarissimo comico che, nel corso del suo talk show quotidiano prende in giro i politici e si fa portavoce di una nazione delusa ed esasperata, che non crede più nella partecipazione democratica. Così il pubblico gli chiede di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti.Lui allora fonda un movimento popolare con il quale, rifiutando i condizionanti ed interessati finanziamenti delle lobbies private, si presenta alle elezioni. E - clamorosamente - le vince.
Peccato, però, che la sua vittoria sia dovuta a un pasticcio del nuovo sistema elettorale informatico. Dell’errore si accorge solo una progettista del sistema, Eleanor Green, che ingenuamente ne informa la sua società. La quale, ovviamente non ha affatto interesse a rivelare una notizia che la porterebbe al fallimento, e quindi cerca prima di screditare la sua dipendente, e poi di ucciderla.
Fin qui il film cresce di tensione, ma poi diventa sempre meno plausibile. Eleanor si rivolge al nuovo presidente eletto, Dobbs. Lui crede a quello che lei racconta e ne informa il paese. Rinuncia e cede il posto ai politici che aveva combattuto.
Il film scivola gioiosamente, ma senza approfondirli, su temi di grande attualità, assolutamente centrali nelle moderne democrazie. C’è il troppo spazio che diamo alla tecnologia (ovvio il riferimento alla prima elezione di Bush); c’è la crescente disaffezione dei cittadini dalla politica; la capacità della televisione nel creare dal nulla nuovi personaggi e movimenti politici; l’incredibile scambio di ruoli tra organi di informazione e spettacoli di intrattenimento; il ruolo sempre crescente e corruttivo delle lobbies economiche; il peso dei conflitti di interesse nella politica.
Noi italiani possiamo trovare tante spaventose analogie nei problemi denunciati dal film: nel nostro paese il giornalismo d’inchiesta lo fanno ormai solo il Gabibbo e le Iene. A fustigare il potere è rimasto solo Beppe Grillo (di cui Dobbs sembra una versione più divertente e meno scalcinata). Un uomo solo ha potuto fondare un intero movimento politico grazie al potere della televisione, e tanti capipopolo hanno dato di sé, messi di fronte ai fatti, una ben misera prova.
Temi forti, dunque, ma approcciati in modo del tutto superficiale. Il regista Barry Levinson aveva in mano un materiale incredibile, poteva fare un film enorme, l’erede di “Deadline” di Brooks (quello dove Humprey Bogart dice “è la stampa bellezza, e tu non puoi farci niente”), di “Quarto Potere” di Welles, di “Quinto Potere” di Lumet.
Invece ha cucinato un film che è un flop esattamente come la figura di presidente che racconta: il tradimento dello spettatore va di pari passo col tradimento degli elettori da parte di un aspirante politico che delude le attese. Peccato, perché la prima parte del film è efficacissima, si ride a crepapelle, e si sogna ad occhi aperti: magari avere un politico che parla così, chiaro e schietto. La seconda è deludente e manca di spessore psicologico.
Il punto centrale del film non è (emerita sciocchezza scritta dai critici italiani) come potrebbe essere l’America governata da un comico. In America non ci sono caselline e caste, la gente può essere ciò che vuole (semmai evita di tenere il piede in due staffe, e un imprenditore che si da alla politica smette di fare l’imprenditore, punto e basta - ogni riferimento non è casuale), e gli USA sono già stati governati da un attore, che fu un grande presidente, Reagan.
Il vero tema è invece il rapporto che ciascuno di noi ha con il potere.
Mi interrogo sin dai tempi del liceo sui rapporti col potere (sin da quando cioè il mio prof di letteratura mi metteva in contatto con grandissimi scrittori che avevano molto elaborato sul tema). E oggi, sono, a tutti gli effetti, un uomo di potere. Dirigere due uffici della P.A. non è gran cosa, beninteso, ma ho pur sempre la responsabilità di una frazione dello Stato. Faccio cioè parte, nel mio piccolo, di quella categoria sociale, che si usa definire “classe dirigente”, e che comprende politici, dirigenti, manager, allenatori, direttori d’orchestra: tutte quelle persone, insomma, il cui compito è dire agli altri cosa devono fare e come, governare gruppi sociali evitando che il confronto e la competizione, al loro interno e tra di loro, degenerino in guerra civile, ed anzi cercando di condurre tante brillanti individualità alla cooperazione in vista di risultati condivisi.
So per esperienza che a questa categoria di relativamente pochi “attori” si contrappone una massa di “spettatori” tanto ipercritici quanto poco desiderosi di assumersi responsabilità dirette, e ben felici di delegare ai primi riservandosi il diritto di mugugnare.
I tifosi che affollano spalti degli stadi credono di sapere allenare meglio degli allenatori, e i loggionisti all’Opera ritengono di poter dirigere meglio del direttore d’orchestra: a criticare sono buoni tutti – ed in fondo il diritto di criticare è compreso nel prezzo del biglietto - ma sono davvero pochi coloro che hanno davvero voglia di impegnarsi. Fare il capo è una faccenda assai meno facile di quanto si pensi, e molto meno divertente: datemi retta, colui che coniò il proverbio “è meglio comandare che fottere” non sapeva evidentemente di cosa stava parlando.
Il modo di conseguire il potere è del tutto secondario. Certo, il corretto svolgimento del processo elettorale (o di un concorso) è questione capitale in una democrazia. Ma elezioni e concorsi, la democrazia, insomma, sono solo un metodo, che non garantisce nulla di per sé: per secoli la selezione della classe dirigente è stata affidata al caso, all’eredità, alla forza bruta. Non è statisticamente provato che la democrazia selezioni i migliori: è solo il mezzo più pacifico ed efficiente, perché, come scrisse Einaudi, contare teste è meglio che spaccarle.
Chi cerca il potere, a prescindere dai metodi con cui lo consegue, sente di avere un progetto, un’idea che vuole realizzare. Nelle persone di potere c’è un’immensa forza creatrice, e non a caso, spesso potere ed arte vanno a braccetto insieme.
E allora, è credibile il personaggio chiave, un uomo che - arrivato al potere limpidamente, sia pure grazie ad errori non suoi - posto di fronte all’alternativa drammatica tra la possibilità di mettere in pratica le proprie idee e fare del bene, ma a prezzo di un compromesso, o rinunciare a tutto, non si sente dilaniato, ma si libera della carica appena conquistata con la stessa facilità con cui ci si toglie un cappotto? Davvero un uomo vero in una simile situazione non sentirebbe le seduzioni del potere, le sue ammalianti sirene? Non passerebbe notti insonni in tormentosa solitudine meditando su cosa è davvero giusto fare? Non sentirebbe la tentazione di accettare in nome del primo principio della politica per cui “il fine giustifica i mezzi”?
Non me la bevo: quello che Williams impersona non è un uomo integro, ma solo un fifone. Cioè qualcuno che, avuta la bicicletta, si accorge di quanto è faticoso pedalare, e afferra il primo pretesto possibile per rinunciare. Come ben intuiva Dioniso di Siracusa proponendo a Damocle di scambiarsi i posti, tutti vedono i privilegi del potere, e lo ambiscono fin quando non si rendono conto di quanti rischi, responsabilità e fatica esso comporta.
Sarebbe stato ben altro film se il regista e il principale attore fossero stati capace di domandare ad ogni spettatore, dopo avergli fatto fare tante risate: ma se tu avessi – anche per caso, o immeritatamente - il potere di cambiare le cose, lo accetteresti? Ne assumeresti il peso? O fuggiresti?
Ognuno di noi si ritrova, a un certo punto - per scelta, caso o destino - a recitare una parte. Il filosofo Epitteto prescriveva all’uomo di recitarla bene. E non casualmente Dante tacciava di “viltade” colui che fece il “gran rifiuto”.
Solo che di questi vili, lamentosi per di più (Gramsci li chiamava ‘gli indifferenti’), il mondo è pieno. Quelli che mancano, drammaticamente, sono i leader coraggiosi e le persone di buona volontà.
PS: a ripensarci, era molto meglio la prova di Eddie Murphy ne "Il distinto gentiluomo" (1992), dove un truffatore riesce a farsi eleggere al Congresso degli Stati uniti con lo scopo di profittare del denaro dei lobbysti, ma quando è dentro scopre quanto la politica è corrotta e contribuisce a fare arrestare alcuni ladri tra i deputati. Come a dire che un malvivente è un semplice dilettante rispetto ai professionisti della politica. Caustico.
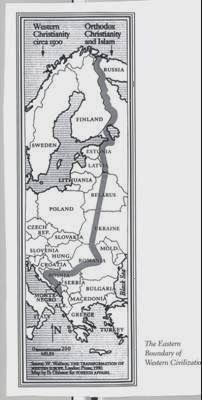
Commenti
Posta un commento